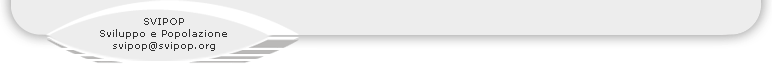Al summit internazionale sullo sviluppo sostenibile svoltosi dal 5 al 7 febbraio a New Delhi, intitolato ‘Oltre Copenhagen: nuovi percorsi di sviluppo sostenibile’, il global warming è stato ancora una volta uno dei temi centrali benché ogni giorno nuove rivelazioni smentiscano le teorie dell’Ipcc, l’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite.
Abdoulie Janneh, il vice segretario generale dell’ONU che inoltre presiede l’Uneca, la Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa, ha infatti ribadito la necessità di soccorrere l’Africa fornendola di un “sostegno finanziario credibile” (è da intendersi ‘cospicuo’) per i danni già patiti e per quelli incombenti in conseguenza del riscaldamento globale. Ha anche affermato che nazioni e imprese private dei paesi più industrializzati colpevoli di inquinare devono impegnarsi quanto prima a limitare le rispettive emissioni di gas serra assumendosi l’onere economico delle trasformazioni tecnologiche necessarie: preferibilmente entro fine anno, in occasione del prossimo vertice ONU sul clima di Città del Messico.
Né si sono sognati di accantonare il cambiamento climatico come fattore di povertà e di denutrizione i partecipanti al Forum di Bamako, l’incontro organizzato dall’Istituto di studi superiori del Mali che ogni anno riunisce per alcuni giorni nella capitale del paese africano alcune centinaia di esponenti di istituzioni internazionali, di governi e soprattutto di organizzazioni non governative. Quest’anno l’evento, alla X edizione, si è tenuto dal 17 al 20 febbraio ed è stato dedicato al tema ‘L’Africa 50 anni dopo l’indipendenza: la sfida della fame nel continente’.
Il punto di partenza delle discussioni dei partecipanti è stata la constatazione che 50 anni fa l’Africa esportava prodotti agricoli alimentari mentre ora importa circa un terzo del proprio fabbisogno alimentare. Che cosa è andato storto?
Oltre che dal riscaldamento globale, secondo gli esperti riuniti a Bamako, la sicurezza alimentare degli africani è stata compromessa dalla crisi finanziaria internazionale. Inoltre sono stati evidenziati come maggiori responsabili della situazione attuale fattori di più lungo periodo. Baba Dioum, coordinatore della Conferenza dei ministri dell’Agricoltura dell’Africa centrale e occidentale, ha puntato l’indice contro il “modello industriale e produttivista imposto all’agricoltura dal Wto”. Moussa Alassane Diallo, direttore della Banca per lo sviluppo agricolo del Mali, si è invece concentrato sulla “progressiva marginalizzazione” subita dall’Africa subsahariana “durante il processo di globalizzazione” che ha avuto “gravi conseguenze sulla produttività agricola, oggi la più bassa del mondo”.
Il Primo Ministro del Mali, Modibo Sidibé, nel suo intervento al forum ha commentato, approvando l’obiettivo proposto di far sì che l’Africa conquisti al più presto la “sovranità alimentare”: “la fame non è una fatalità a cui bisogna rassegnarsi, ma la conseguenza di una ingiusta ripartizione del cibo che il nostro pianeta produce”.
È proprio a partire da quest’ultima affermazione che si vogliono proporre alcune considerazioni.
L’espressione il “cibo che il nostro pianeta produce” può essere un modo come un altro per riferirsi alla quantità complessiva dei raccolti alimentari disponibili, ovviamente prodotti dall’uomo, non “dal pianeta”. Tuttavia, poiché è associata all’affermazione che la fame in Africa è conseguenza di una ingiusta ripartizione del cibo, quell’espressione forse non è casuale, ma piuttosto scelta condividendo e riproponendo una classica asserzione terzomondista secondo cui le risorse alimentari esistenti sarebbero più che sufficienti a sfamare tutti gli abitanti della Terra se fossero distribuite equamente invece di essere per l’80% consumate dal 20% della popolazione, quella che vive nel cosiddetto nord del mondo: dove ‘equamente’ significa ‘in parti uguali’, a prescindere da chi quelle risorse ha creato.
Infatti parlare di ciò che ‘il pianeta produce’ distoglie dal fatto fondamentale che quel 20% di popolazione con il suo lavoro produce le risorse di cui si sazia e gode: e in quantità tali da poterne vendere e donare una parte al resto del pianeta in difficoltà.
Un Primo Ministro, questo è il punto, non dovrebbe mascherare i problemi del proprio paese e del continente africano dietro argomenti terzomondisti né dovrebbero farlo ministri e direttori di banche centrali. Non dovrebbero farlo neanche i giornalisti, per la responsabilità che deriva loro dall’enorme influenza dei mass media sull’opinione pubblica, e invece succede di continuo.
Uno degli esempi più recenti è stato offerto dal giornalista italiano Massimo Fini che, pur non essendo affatto esperto d’Africa, ha scritto quanto segue in un articolo molto ripreso dai siti internet, specie quelli delle organizzazioni non governative: “L’opinione pubblica occidentale, anche a causa della disinformazione sistematica dei suoi media, è convinta che la fame in Africa sia endemica, che esista da sempre. Non è così. Ai primi del Novecento l’Africa nera era alimentarmente autosufficiente. Lo era ancora, in buona sostanza (al 98%) nel 1961. Ma da quando ha incominciato ad essere aggredita dalla pervasività del modello di sviluppo industriale alla ricerca di sempre nuovi mercati, per quanto poveri, perché i suoi sono saturi, la situazione è precipitata. L’autosufficienza è scesa all’89% nel 1971, al 78% nel 1978. per sapere quello che è successo dopo non sono necessarie le statistiche, basta guardare le drammatiche immagini che ci giungono dal Continente Nero”.
Non dovrebbe sfuggire – è questa la seconda considerazione – il fatto che il periodo di autosufficienza alimentare così individuato è quello coloniale europeo e che la progressiva dipendenza dell’Africa da generi alimentari importati si verifica proprio a partire dal decennio delle indipendenze. Benché nessuno sembri prenderlo in considerazione, l’elemento determinante si direbbe quindi essere questo: la colonizzazione europea e i fattori di sviluppo che ha introdotto nel continente e che gli africani non hanno poi messo a frutto quando sono diventati padroni del loro destino. Ad affamare la popolazione rurale africana, inducendone una parte crescente ad abbandonare le colture destinate al mercato per tornare a praticare economie di sussistenza oppure a emigrare nei centri urbani, trovando occupazione nel cosiddetto settore informale, non sono stati i tanto criticati aggiustamenti strutturali imposti dalla Banca Mondiale e dal Fondo monetario internazionale, peraltro mai del tutto attuati, ma piuttosto le casse di stabilizzazione dei prezzi ereditate dalle amministrazioni coloniali e trasformate in sistemi istituzionalizzati di prelievo dei redditi dei contadini: e questa è soltanto una delle politiche economiche disastrose attuate dopo le indipendenze, a cui si devono aggiungere gli effetti catastrofici delle guerre civili e della sistematica appropriazione delle ricchezze nazionali da parte delle leadership autoctone man mano avvicendatesi al potere negli ultimi 50 anni.
Va detto poi, come terza considerazione, che l’intenzione terzomondista di mettere in cattiva luce sempre e comunque l’Occidente e il suo modello economico-sociale gioca davvero brutti scherzi se induce ad affermazioni madornali come quella che fino all’inizio degli anni 60 del secolo scorso in Africa non si patisse la fame. La gran parte della popolazione infatti continuava a dipendere da economie di sussistenza e quelle tribali africane erano e sono tra le meno capaci di produrre risorse: le tecnologie rudimentali e la divisione del lavoro che le caratterizzano assicurano sicurezza alimentare soltanto in condizioni climatiche del tutto favorevoli. Perciò, benché durante l’epoca coloniale il Pil crescesse costantemente e in effetti si esportassero raccolti alimentari, anche allora le carestie continuavano come nel passato a essere frequenti e devastanti.
La differenza piuttosto è che qualche volta durante il periodo coloniale europeo, grazie a governi disposti a intervenire in situazioni di emergenza e all’esistenza di strade, ferrovie, mezzi di trasporto moderni (e prima di tutto di mezzi di comunicazione che permettevano di venire a conoscenza dell’insorgere di carestie), le popolazioni, almeno nelle regioni collegate ai centri amministrativi ed economici, ricevevano aiuti alimentari e assistenza sanitaria. Sulla costa swahili del Kenya, ad esempio, una grave carestia verificatasi alla fine del XIX secolo si ricorda come la “carestia del mais ‘rosso’ portato dal governo” oppure come “la fame dei sacchi” perché il governo coloniale britannico aiutò le tribù colpite importando del mais giallo (quello locale è bianco) che arrivò a destinazione confezionato in sacchi. Sempre sulla costa swahili un’altra carestia, tanto prolungata ed estesa da essercene tuttora memoria, si verificò intorno al 1945 ed è ricordata come “la fame della coda” perché il governo coloniale istituì dei centri di distribuzione di cibo dove affluivano migliaia di persone e la gente doveva mettersi in coda aspettando il proprio turno.
Per finire, ed è l’ultima considerazione, si sa che non giova mai alla soluzione dei problemi falsificare i fatti in funzione del rafforzamento di un’ideologia: in questo caso quella terzomondista avversa all’Occidente. Ignorando e negando le cause reali delle crisi africane, si sono sprecate e si continuano a sprecare infinite risorse umane, tecnologiche e finanziarie in rimedi inutili e spesso persino controproducenti, con conseguenze a volte terribili, come è successo in Zimbabwe quando il governo del presidente Robert Mugabe, all’inizio del secolo, invece di combattere corruzione e malgoverno, ha espropriato migliaia di fattorie che producevano per il mercato internazionale e interno sostenendo che contro la povertà era indispensabile una riforma agraria che trasformasse le grandi proprietà in piccoli appezzamenti familiari e i braccianti in proprietari terrieri. Privi di mezzi, di esperienza e di accesso a crediti bancari, la maggior parte dei nuovi coltivatori autonomi, spesso neanche forniti di diritti di proprietà, da allora hanno coltivato con scarsi risultati terreni prima fertili e redditizi regredendo a forme di economia di sussistenza. Altri terreni, lasciati incolti, sono stati sommersi dalla vegetazione spontanea diventando del tutto improduttivi. Il risultato è stato una delle più drammatiche crisi economiche del continente africano che ha costretto un quarto della popolazione a emigrare e un terzo, rimasto in patria, a dipendere dagli aiuti alimentari internazionali per sopravvivere, mentre l’inflazione portava il costo di una pagnotta di pane a 100 miliardi di dollari zimbabwani e i negozi si svuotavano delle merci. |