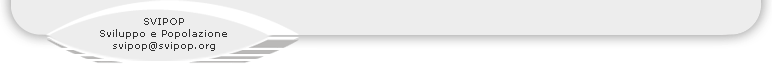Una buona notizia dall’Africa, una volta tanto, meriterebbe molta più attenzione di quanta ne abbia ricevuta. Si tratta dell’Etiopia che ha annunciato di aver completato in questi giorni la distruzione delle proprie scorte di mine antiuomo, anticipando di alcune settimane la data del prossimo giugno fissata dal Trattato di Ottawa, la convenzione internazionale entrata in vigore nel 1997 alla quale l’Etiopia ha aderito impegnandosi, come tutti gli altri paesi sottoscrittori, a non usare mine antiuomo, non trasportarle né produrle, distruggere quelle in suo possesso e liberare i propri territori infestati.
In tutto sono stati distrutti 54.000 ordigni, conservandone un migliaio per le esercitazioni delle squadre di sminatori.
Si può apprezzare appieno la notizia soltanto se si conoscono gli effetti terribili di questo tipo di arma, un vero e proprio flagello che prolunga a tempo indeterminato gli effetti di guerre già di per se stesse devastanti aggiungendosi agli altri fattori che rallentano i processi di crescita economica e di sviluppo umano.
Le mine antiuomo vengono sepolte nel terreno per impedire l’accesso dei nemici a determinate zone e quindi rallentarne l’avanzata e limitarne i movimenti. Quelle inesplose al termine di un conflitto rendono impraticabili le aree in cui sono state disseminate. Non vi si può transitare e tanto meno abitare, coltivare la terra, pascolare il bestiame. Spinti dalla necessità, però, si finisce per farlo lo stesso, correndo tutti i rischi che ciò comporta. Di innumerevoli ordigni, poi, non si conosce la collocazione e quindi non vi è modo di circoscrivere i territori minati: atti quotidiani come raccogliere legna e attingere acqua diventano allora pericolosi come una roulette russa.
Ogni anno sono migliaia le vittime, civili al 90%, delle decine di milioni di mine disseminate in oltre 80 Stati, per lo più in via di sviluppo. Chi non muore per l’esplosione, camminandoci sopra, resta ferito in maniera più o meno grave, ma quasi sempre con conseguenze permanenti: molte sono le amputazioni e le lesioni alla vista e all’udito. Una percentuale elevata di casi riguarda dei bambini: questo perché nei paesi a maggiore concentrazione di mine antiuomo – per lo più asiatici e africani – molti minori lavorano nei campi, pascolano il bestiame e svolgono mansioni domestiche che li espongono al pericolo. Succede anche di frequente che i bambini scoprano gli ordigni giocando e non ne capiscano la funzione, li scambino per giocattoli o per oggetti innocui, finendo per farli esplodere.
Dai dati forniti dall’Unicef risulta inoltre che la maggior parte dei bambini feriti dalle mine antiuomo – forse addirittura l’85% – muoiono prima di essere ricoverati in un ospedale: specialmente se l’incidente si verifica mentre lavorano lontano da casa, ad esempio mentre accudiscono un gregge o una mandria, e i familiari si accorgono di quanto è accaduto troppo tardi per salvarli.
Quasi sempre, infine, le famiglie dei piccoli superstiti non sono in grado di affrontare il costo delle cure mediche e soprattutto delle protesi eventualmente necessarie che per di più, trattandosi di bambini, devono essere adattate continuamente durante la crescita. Il risultato è che molti dei bambini che sopravvivono sono destinati da adulti a una vita da reietti perché incapaci di lavorare, di formare una famiglia e di essere autosufficienti.
L’Etiopia è uno dei paesi che in passato ha impiegato grandi quantità di mine antiuomo. L’ultima occasione è stato il conflitto con l’Eritrea per questioni di confine, che si è concluso nel 2000, senza tuttavia risolversi del tutto, dopo una guerra durata due anni.
Come l’Angola, il Mozambico e altri Stati africani, le resta ora da risolvere il problema cruciale, assai oneroso e complesso, della bonifica dei territori minati che, sempre in base al Trattato di Ottawa, dovrebbe essere completata entro il 2015.
|